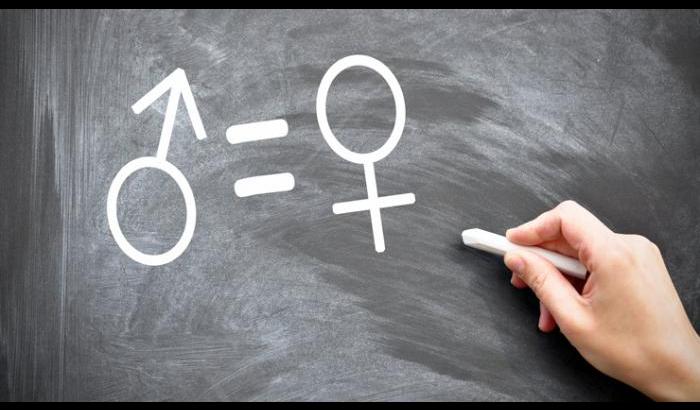Nella Fase 1 sono state in prima linea per fronteggiare l’emergenza. Nella Fase 2 rischiano di pagare il conto più salato della crisi. Ma su di loro occorre puntare per ricostruire il Paese, a partire dal welfare e dalle infrastrutture immateriali.
Si calcola che ben più del 50% di quanti hanno lavorato in prima linea durante la Fase 1 siano donne. Personale sanitario, certo, ma anche cassiere, commesse, operatrici ecologiche e delle forze dell’ordine, addette alla sanificazione e al pulimento. E si stima, perché dati disaggregati per genere non ne esistono e questo la dice lunga, che circa il 60% di quelli posti in cassa integrazione siano ancora donne. Di conseguenza il rischio che alla scadenza delle settimane di cassa integrazione per Covid-19 e al termine di blocco dei licenziamenti a perdere il lavoro siano prevalentemente le lavoratrici è assai alto.
Insomma, se ci si domandasse chi paga la crisi la risposta sarebbe assai semplice.
È bene ricordare, inoltre, che il tasso di occupazione femminile già prima della crisi sanitaria era ben al di sotto del 50%, assai più basso della media Ue. Fra i grandi paesi europei il nostro mercato del lavoro include la quota più bassa di donne occupate pari al 42,5% del totale, a fronte di una media europea del 46%, e valori ancora più elevati di Francia (48,3%) e Germania (46,7%). Secondo il Centro di ricerca economica Rur Rete Urbana di rappresentanza: “Per portare l’Italia al valore medio europeo sarebbero necessari 1.617.000 nuovi posti di lavoro esclusivamente destinati alle donne, se si volesse almeno dimezzare il divario con l’Europa bisognerebbe porsi l’obiettivo di almeno 250.000 nuove occupate l’anno per il prossimo triennio”.
Aumentare l’occupazione femminile, la Consulta degli economisti della Cgil lo sostiene da tempo, sarebbe un grande volano per l’economia del Paese proprio per questa ragione già nel settembre del 2016 la Confederazione presentò un “Piano straordinario per l’occupazione dei giovani e delle donne”. Oggi puntare su di esse sarebbe conveniente anche dal punto di vista sanitario.
Sempre Rur, in un interessante studio intitolato “Le energie femminili indispensabili per ripartire” mette in evidenza che “I dati più recenti (al 7 maggio) confermano una maggiore resistenza delle donne alle conseguenze estreme provocate da Covid-19, in particolare per le fasce d’età lavorativa maggiormente interessate alla progressiva riapertura delle attività. Il tasso di letalità dovuta al virus (decessi su positivi) per le persone fra 20 e 59 anni risulta, infatti, del 2,4% per gli uomini e dello 0,5% per le donne”.
Puntare sulle donne, dicevamo, sarebbe strategico. Ma in Italia servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la cura di anziani o non autosufficiente, ce ne sono assai pochi e il lavoro di cura grava quasi esclusivamente – appunto – sulle donne. E in periodo di tutti a casa, con scuole e asili chiusi, le cose sono, se possibile, peggiorate.
Secondo le studiose Daniela Del Boca, Noemi Oggero, Paola Profeta, Maria Cristina Rosse e Claudia Villosio in una ricerca sulle diseguaglianza nel lavoro tra le mura domestiche pubblicata da InGenere (rivista online di informazione, approfondimento, dibattito e proposte su questioni economiche e sociali, analizzate in una prospettiva di genere): “Il 68% delle donne lavoratrici con partner ha dedicato più tempo al lavoro domestico durante il lockdown rispetto alla situazione precedente, il 29% ha dedicato lo stesso tempo e solo il 3% ve ne ha dedicato di meno. Guardando invece ai partner, solo il 40% ha dedicato più tempo al lavoro domestico, mentre la maggior parte (il 55%) non ha modificato il proprio comportamento in casa (solo il 6% lo ha diminuito).
Per le coppie con figli, se analizziamo il tempo dedicato dai genitori alla loro cura, vediamo che la maggior parte delle donne lavoratrici (61%) lo ha aumentato. Solo il 34% ha lasciato inalterato il proprio impegno (e appena il 5% lo ha ridotto). Anche la maggioranza degli uomini ha aumentato il tempo dedicato alla cura dei bambini, ma la percentuale si ferma al 51%. Ben il 45% non ha modificato il proprio comportamento (e solo il 3% ha ridotto il tempo di cura)”.
Questi dati sul lavoro di cura, ovviamente, riguardano prevalentemente le donne che durante la Fase 1 hanno lavorato in smart-working. Interessante a questo proposito la Ricerca promossa dall’ufficio politiche di genere della Cgil in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio la cui presentazione è stata data in diretta su Collettiva.it.
E cosa stia accadendo nella Fase2 con il rientro al lavoro, ma con scuole e asili chiusi, è facile da immaginare visto che le lavoratrici con figli al di sotto dei 14 anni sono ben 3 milioni e certo la soluzione non è né nel bonus baby sitter né nei congedi parentali contenuti nel “decreto rilancio” che, come ha ricordato recentemente Susanna Camusso, responsabile politiche di genere della Cgil, sono senza stipendio e senza contributi previdenziali.
Che fare? Puntare sull’occupazione femminile, partendo dalle sfide che la pandemia pone a cominciare dalla ricostruzione del welfare quasi azzerato da 15 anni di liberismo e di conseguente restringimento del perimetro pubblico. Tra risorse europee e risorse interne sono davvero molti i miliardi destinati alla ripartenza del Paese, le donne italiane sono qualificate, forse più degli uomini, per essere le protagoniste della rinascita, già oggi – è sempre il Centro studi Rur ha sottolinearlo: “Il livello d’istruzione delle donne occupate è maggiore addirittura in valori assoluti rispetto a quello maschile. Sono, infatti, circa 3 milioni le donne laureate impiegate in un’attività produttiva, a fronte di 2,5 milioni di uomini”.