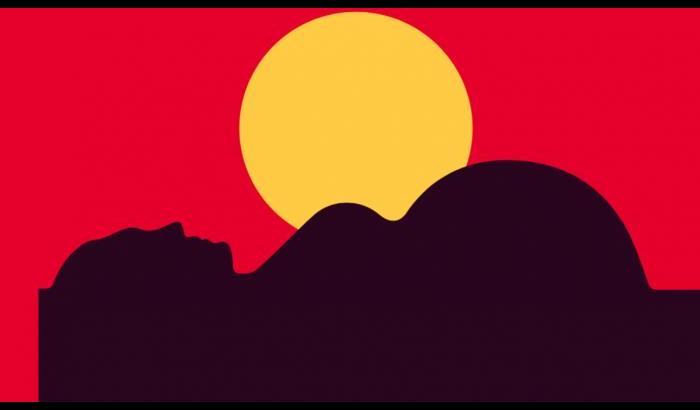È davvero così inverosimile, distopico come l’hanno definito in molti, concepire (è proprio il caso di dirlo!) un resort gestazionale in cui mettere a disposizione il proprio utero per consentire a una donna che non può o non vuole permetterselo (perché non ha più l’età, non ha il tempo, non vuole perdere la linea) di avere un figlio?
È quello che fa Joanne Ramos ne “La fabbrica”, il suo esordio letterario, dove protagoniste sono alcune donne che scelgono di andare a Golden Oaks, un paradiso hi-tech a due ore da Manhattan, per portare avanti la gravidanza di un’altra. Non è un atto di generosità estrema, anche se qualcuna vorrebbe convincersi del contrario, né una situazione a cui non possono sottrarsi, come invece avviene ne “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood a cui questo libro è stato avvicinato. La maternità surrogata è una scelta. Una scelta su cui Ramos non esprime giudizi.
Ma è una scelta libera? La mancanza di alternative concrete riduce la libertà, la dematerializza, e la maggior parte delle ospiti di questa clinica di lusso sono filippine o caraibiche, poche polacche e russe. Filippina è Jane, la protagonista, una giovane madre single con una bimba di pochi mesi e un matrimonio fallito alle spalle, che non ha finito il liceo e ha già perso più di un lavoro; ma filippina è anche l’autrice, arrivata nel Wisconsin a sei anni, che tuttavia ha studiato a Princeton.
Da giornalista economica qual è, ha voluto chiedersi cosa succede alla gravidanza quando si trasforma in una transazione economica, partendo dal presupposto che normalmente tutto ciò che non è pagato diviene improvvisamente invisibile: ci basti pensare al lavoro delle donne a sostegno della genitorialità e della cura dei figli in questo momento di emergenza, un lavoro non solo non riconosciuto e non retribuito, ma che addirittura impedisce il tradizionale lavoro fonte di reddito.
Da filippina incarnazione del così detto “sogno americano” ha voluto ascoltare e raccontare le storie di tante conterranee, dalle quali la separa un abisso fatto di disuguaglianze, dove la fortuna ha più spazio del merito.
Ma non c’è nessuna presa di posizione nella sua scrittura, solo la capacità di trasmettere la lucida consapevolezza che, sebbene una volta entrate nella spa sull’Hudson dove si fabbricano bambini perfetti tutte possano godere allo stesso modo di cibo biologico, aria pura, maglioncini di cachemire e cure sanitarie al top (ma non tutte avranno lo stesso compenso: le caucasiche valgono di più), quella decisione, che comporta la rinuncia alla propria libertà, ha implicazioni diverse per ciascuna di loro: per Jane, che intravvede una possibile svolta alla povertà e alla mancanza di futuro per lei e sua figlia; per Reagan, a cui non è mai mancato nulla, che vuole emanciparsi da suo padre e dal suo denaro; per Lisa, che oltre a guadagnare un sacco di soldi vuole dimostrare il suo potere contrattuale.
Ramos non condanna e non assolve nessuna, a tutte restituisce umanità. Persino a Mae, l’imprenditrice senza scrupoli che dirige Golden Oaks, e a Ate, la cugina della protagonista, filippina anche lei, che si rivela non completamente disinteressata. Perché in fondo tutte, anche se in una maniera molto diversa che non si può non tenere in considerazione, abbiamo aderito a un capitalismo sfrenato che può avere, come questo libro per nulla irrealistico dimostra, effetti totalitari.
«Non l’ho scritto per dare risposte, perché non ne ho. Al contrario, questo libro vuol essere un’indagine — per me, e spero anche per i lettori — su chi siamo, su quali siano le nostre priorità e su come vediamo chi è diverso da noi.» afferma l’autrice nella Nota finale. E affida a ciascuna e a ciascuno di noi una domanda: quanto di noi stesse e di noi stessi siamo disposti a trasformare in merce? È vero che in America (e forse non solo in America), come pensa Ate, devi solo trovare il modo di fare soldi e coi soldi ti puoi comprare tutto il resto?
Joanne Ramos, “La fabbrica”, Ponte alle Grazie, Milano 2020, pagg. 414, euro 18,00